Visualizzazione di 15 risultati
-

Rilegare i periodici
2,07 € -
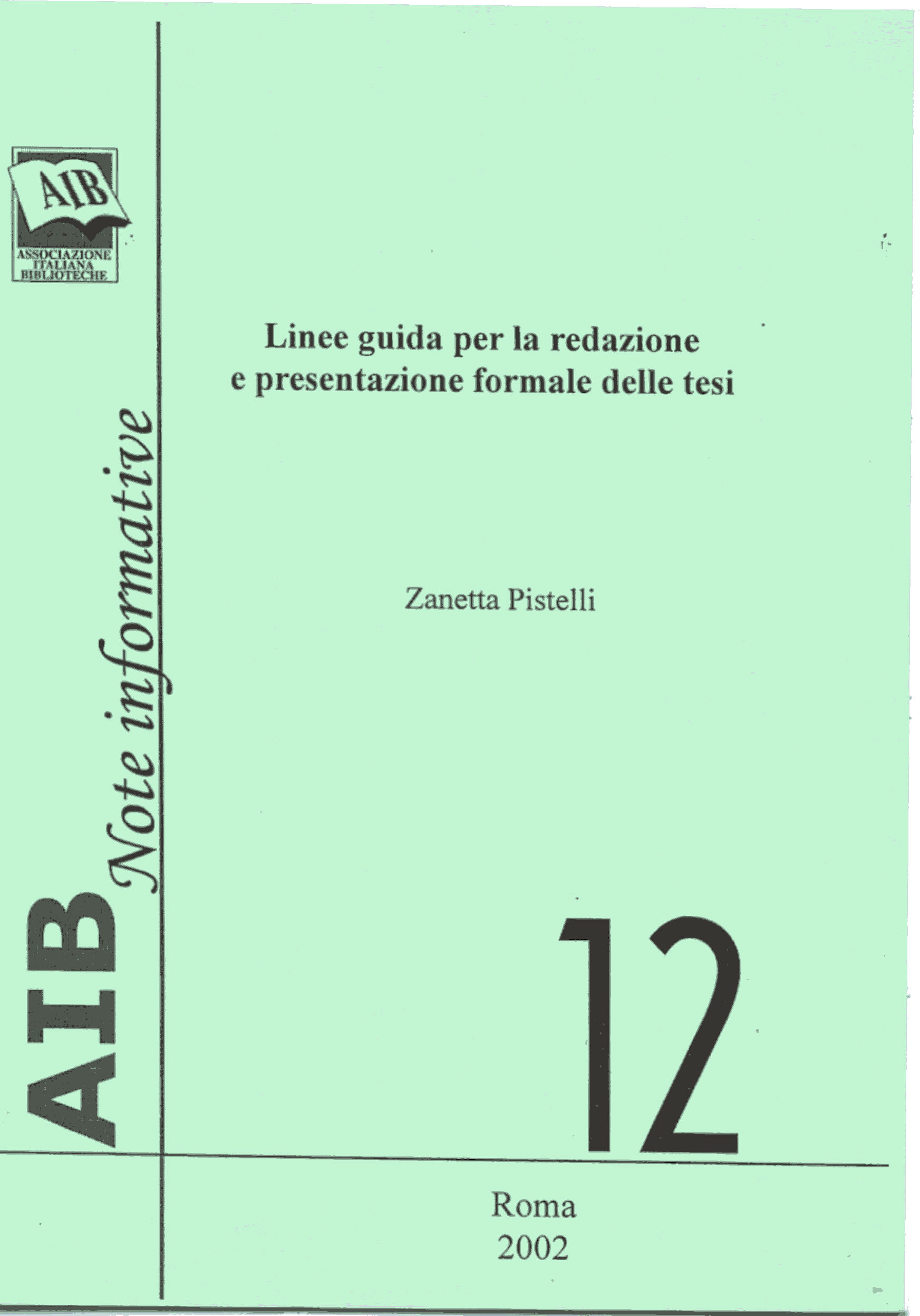
Linee guida per la redazione e presentazione formale delle tesi
2,07 € -

Le versioni gratuite di Medline direttamente gestite e controllate dalla US National Library of Medicine
2,07 € -
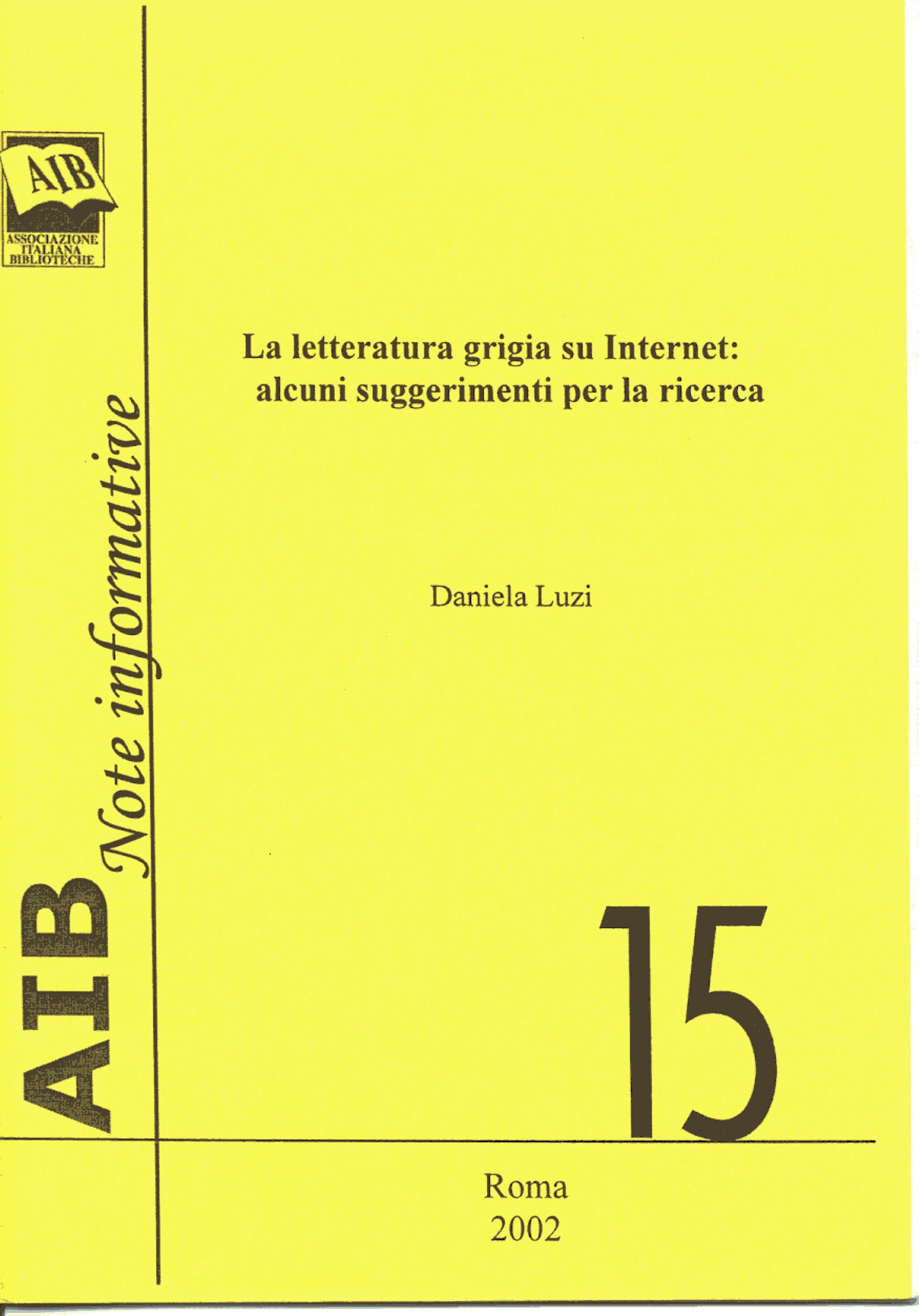
La letteratura grigia su Internet
2,07 € -
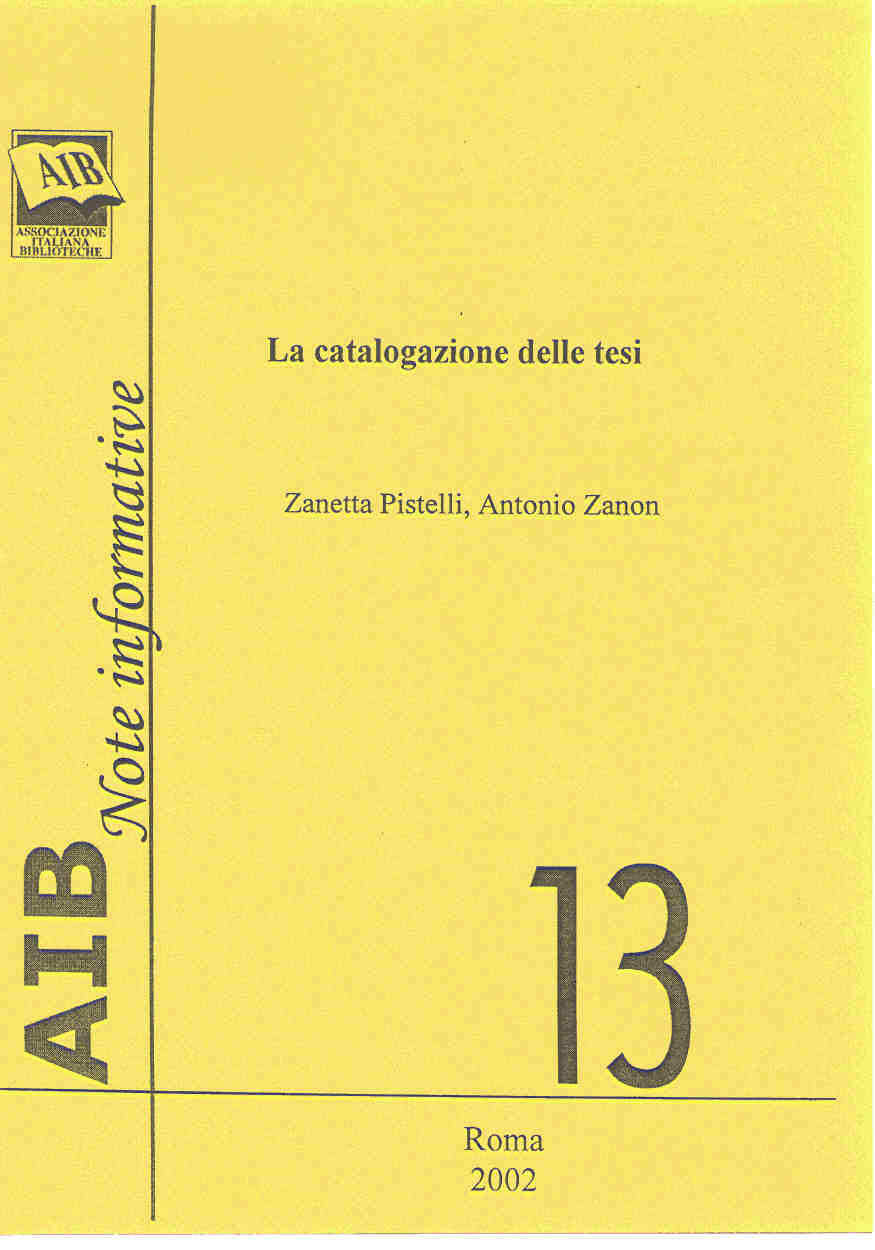
La catalogazione delle tesi
2,07 € -

Il sistema MEDLARS e i suoi archivi
2,07 € -

Il riassunto analitico
2,07 € -
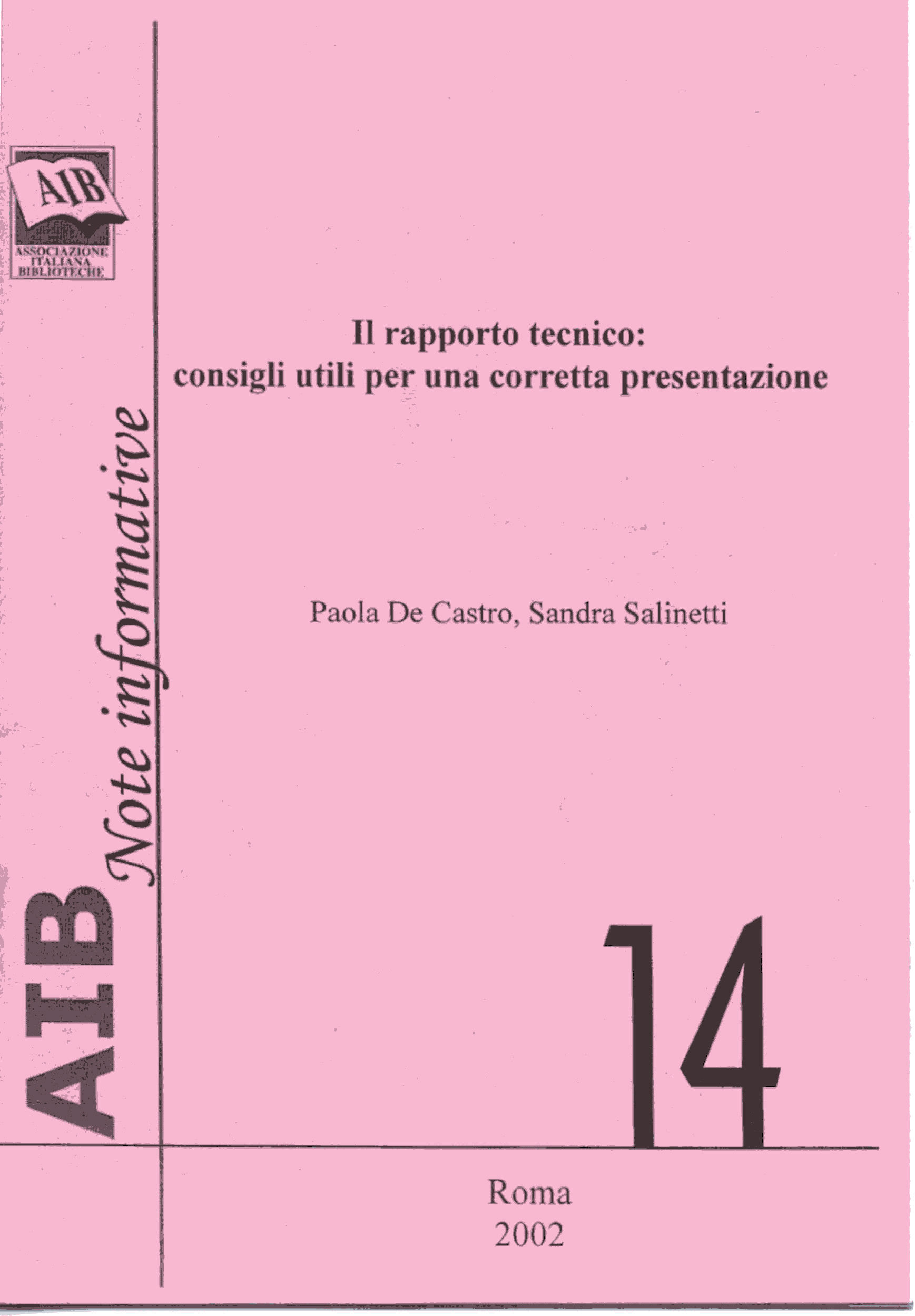
Il rapporto tecnico
2,07 € -

I codici ISSN, ISBN e EAN e altre informazioni utili per chi pubblica
2,07 € -
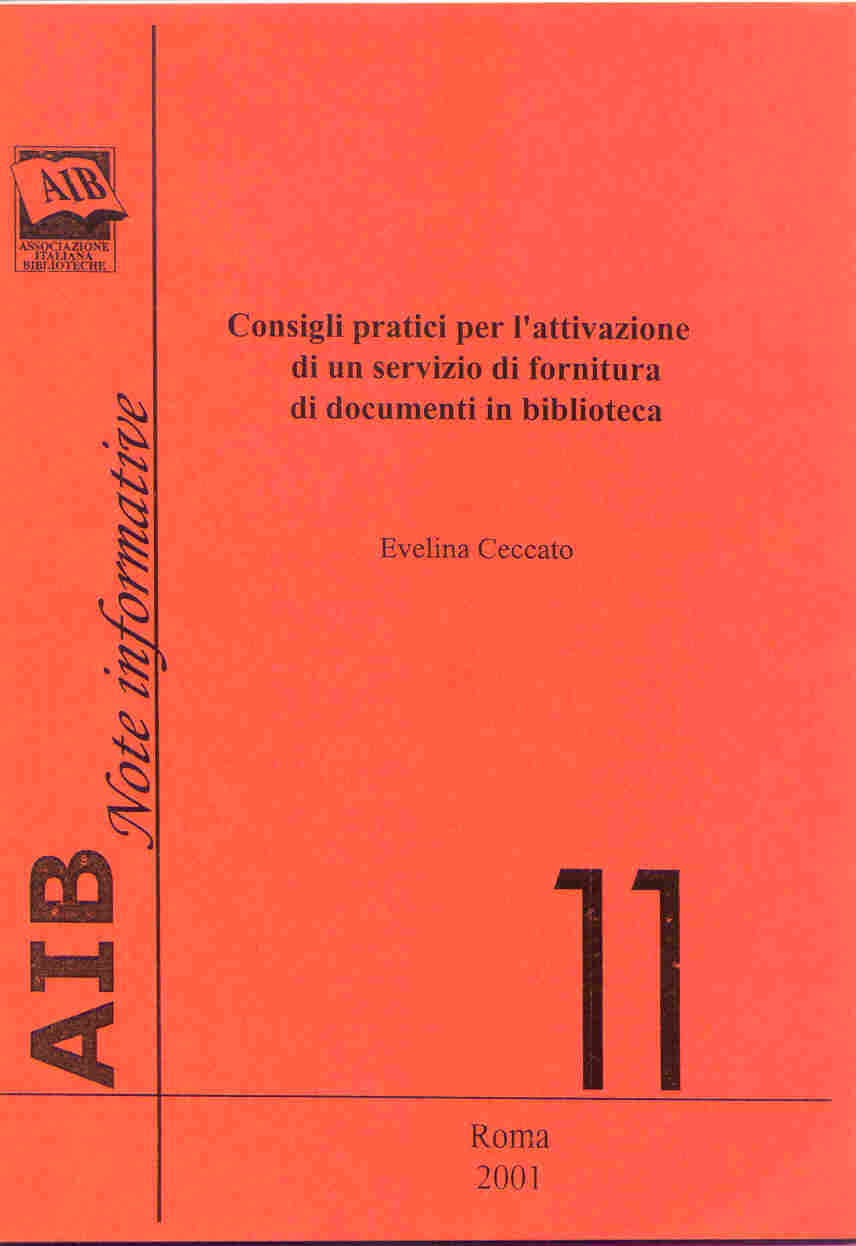
Consigli pratici per l’attivazione di un servizio di fornitura di documenti in biblioteca
2,07 € -

Consigli pratici per l’utilizzazione di Internet in biblioteca
2,07 € -

Consigli pratici per allestire una mostra bibliografica
2,07 € -

Come creare gli indici di una pubblicazione con l’ausilio del personal computer
2,07 € -

Cataloghi di biblioteche e cataloghi collettivi italiani in Internet
2,07 € -

Abbreviazioni, acronimi e simboli
2,07 €


